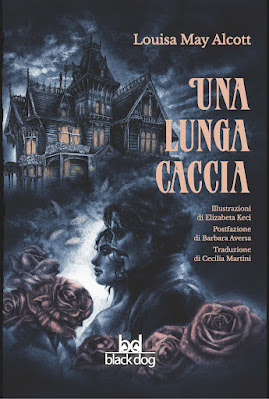Tea
Pecunia, nella sua introduzione, ci presenta l’autore dell’opera: Inazō Nitobe (1862–1933). Inazō
Nitobe trascorse gran parte della sua vita lontano dal Giappone, vivendo per
molti anni negli Stati Uniti e in Europa. Fu una figura straordinariamente
versatile: docente, rettore universitario, economista agrario, diplomatico,
politico e persino esperantista. Credeva profondamente nel progetto
dell’Esperanto, una lingua pianificata per favorire il dialogo tra i popoli,
costruita con elementi provenienti dal latino, dall’italiano, dal francese,
dall’inglese, dal russo e dal polacco.
Forse fu proprio questa sua naturale inclinazione al
dialogo a spingerlo a scrivere la sua opera più celebre, con l’intento di
rispondere alle domande degli occidentali sull’etica giapponese. Il libro lo rese noto
in tutto l’Occidente, pur attirando numerose critiche per alcune inesattezze
storiche, per certi limiti interpretativi e per quelle che alcuni giudicarono
forzature prospettiche. Eppure, ancora oggi, rimane il testo più diffuso sul
Bushidō.
Inazō
Nitobe cerca costantemente di individuare affinità e punti di contatto tra
la cultura occidentale e quella giapponese, un compito tutt’altro che
semplice. Così, ad esempio, mette in relazione lo spirito cavalleresco
medievale con il Bushidō dei samurai: due realtà profondamente diverse, ma
accomunate da alcuni valori morali fondamentali.
La
mia impressione, leggendo anche altri autori giapponesi che trattano gli stessi
temi, è che Inazō Nitobe sia riuscito a “occidentalizzare” il concetto di
Bushidō, rendendolo quindi più accessibile al lettore europeo. La sua
sensibilità, spesso vicina al modo di pensare occidentale, emerge chiaramente e
facilita la comprensione di chi si avvicina a questi argomenti senza alcuna
conoscenza preliminare. Nonostante ciò, il suo pensiero resta profondamente
permeato dalla mentalità giapponese: pur avendo ricevuto un’educazione
occidentale e pur essendosi convertito nel corso della sua vita al
cristianesimo, Inazō Nitobe non rinnega mai il proprio retaggio culturale.
Un po’ come accade a noi italiani che restiamo legati, spesso anche inconsciamente,
alle nostre radici regionali, così Inazō Nitobe rimane profondamente ancorato
alla tradizione del Giappone.
Nel
trattare il tema, l’autore ricorre spesso a parallelismi tratti dalla storia e
dalla letteratura europee, nel tentativo di avvicinare il lettore straniero a
una materia complessa e distante. E, a mio avviso, ci riesce pienamente. Il
testo è suddiviso in vari capitoli, ciascuno dedicato a un aspetto del Bushidō:
le sue origini, le fonti, il carattere, l’insegnamento, l’influenza sulle
masse, la continuità nel tempo e la sua persistenza nel presente. Il Bushidō
viene presentato come un codice morale che i samurai erano tenuti a osservare
con rigore.
Inazō
Nitobe analizza virtù come benevolenza, cortesia, veridicità, onore, dovere,
lealtà e dominio di sé: tutti elementi fondamentali dell’anima del Bushidō.
Alcune descrizioni raggiungono una vera e propria poeticità, come quando
parla delle celebri lame dei samurai, autentiche opere d’arte, che paragona
alle loro rivali occidentali, come la spada di Toledo o quella di Damasco.
In
definitiva, Bushidō è un libro stimolante,
capace di ricostruire con vivacità il Giappone feudale. È un testo
accessibile ai neofiti e a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo
dei samurai, comprendere che cosa sia il Bushidō e quale eredità abbia
lasciato nella cultura giapponese contemporanea. Un’opera che invita a
riflettere su quanto di quell’antica etica sia sopravvissuto nel Giappone
moderno, soprattutto se confrontato con la tradizione cavalleresca occidentale.