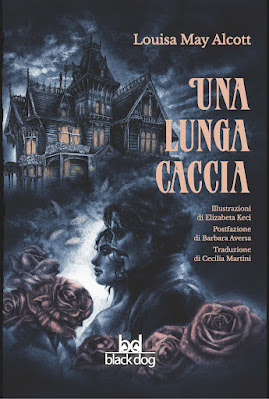Ayres ha ventidue
anni, ma porta addosso un senso di colpa antico, pesante, che le impedisce di
vivere la sua età con la leggerezza che meriterebbe.
La
sua vita scorre in una routine fatta di piccoli lavori: al mattino tra i
profumi di carta e polvere della libreria antiquaria, al pomeriggio tra i
colori delicati di un negozio di fiori. Una
quotidianità silenziosa, quasi sospesa, che sembra proteggerla e imprigionarla al
tempo stesso.
Poi,
il destino bussa alla sua porta. Ha il volto di un ragazzo affascinante, James, che irrompe nella sua vita con una
richiesta impossibile: ha bisogno di lei per spezzare una maledizione lanciatagli da una giovane strega.
Ayres
non sa cosa pensare. Dubbi, paure, esitazioni la assalgono. Eppure, qualcosa
dentro di lei la spinge ad accettare, forse perché quel viaggio non è solo la
ricerca di un modo per sciogliere un incantesimo, ma anche l’occasione per ritrovare se stessa, per capire
finalmente chi è davvero.
“Dryadem. La leggenda” è il primo volume di una trilogia fantasy
decisamente particolare. Non si limita a raccontare una storia di magia: intreccia cultura celtica, miti antichi,
divinità dimenticate, stregoneria e leggende.
Il ritmo iniziale è piuttosto lento e fatica un po’
a ingranare. Tuttavia, una volta che la storia prende avvio, gli eventi si
incastrano con coerenza e la trama si ricompone in modo convincente.
I personaggi sono numerosi, ma è Ayres quella che rimane
nel cuore del lettore e non solo perché è la protagonista della storia. Fragile
e forte, smarrita e determinata, è una giovane che cresce, che sbaglia, che
cerca. Quello di Ayres è un viaggio dentro la magia e dentro se stessa.
Non
è possibile considerarlo un romanzo autoconclusivo: troppi misteri restano
sospesi, troppe domande attendono risposta. E così, una volta chiusa l’ultima
pagina, non resta che proseguire il viaggio ed immergersi nel seguito della
saga.
Una
storia affascinante, ricca di magia e di ombre, che parla di destini
intrecciati e di identità da ritrovare. Un inizio che promette molto e che
invita a restare.